 |
||||||||||
| primo corsivo redazionale | ||||||||||
|
Questa non è una storia, ma l’insieme di tante storie,anche se soltanto accennate, ricordate qui per non dimenticare il contesto laborioso in cui il Villaggio del Sole è sorto. |
||||||||||
|
La strada statale 46, che da Vicenza va verso nord, per noi oggi si chiama strada del Pasubio e Viale Trento. In altri tempi è stata chiamata strada di Vallarsa e di borgo santa Croce. Rispetto al Villaggio del Sole viale Trento costituisce in qualche modo il collegamento principale e l’ingresso “ufficiale”. |
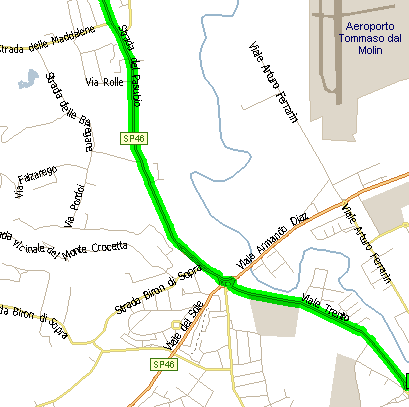 |
|||||||||
|
Da questa parte, infatti, superata la rotonda e giunti su via del Sole, abbiamo la vista completa del Villaggio perché la parte centrale, con la chiesa e gli altri edifici, è più bassa delle case e ci consente, alberi permettendo!, di vedere tutta via Colombo. |
||||||||||
|
Una parte degli abitanti di viale Trento e di via Pasubio fa riferimento al Villaggio del Sole, per la parrocchia e per la scuola, fin dagli inizi del quartiere, così si sono intrecciate le vicende familiari, le attività e gli interessi. |
||||||||||
|
Per ricostruire questo passato recente abbiamo parlato con molte persone delle famiglie che abitavano e lavoravano in questa zona. |
||||||||||
|
Sono nomi che tornano spesso anche nelle nostre storie, come Miolo, Fortunato,Pavan, Dalla Fontana, Povoleri, Calgaro, e altri ancora. Cerchiamo qui di dare un ordine a quanto abbiamo raccolto. |
||||||||||
|
Lungo via Pasubio, in direzione della città,in vicinanza della rotonda, troviamo l’Albera |
||||||||||
|
Oggi è una pizzeria, ma la località e il locale stesso hanno una lunga storia. Qui c’era una trattoria, con gioco delle bocce, che era molto conosciuta e frequentata. |
||||||||||
|
Ne parlano nei loro racconti diverse persone, in particolare la famiglia Calgaro che ha gestito la trattoria, e Povoleri ricorda che il sabato c’erano più persone che sedie. |
||||||||||
|
|
Proprio di fianco alla trattoria esercitava la sua attività Lio Miolo, uno dei fratelli ‘botari’, di cui ha parlato Roberta Dalla Fontana. |
|||||||||
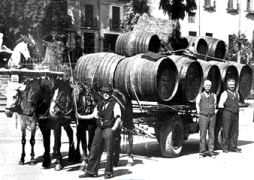 |
||||||||||
|
Lì vicino c’era la fonderia Velo, ora trasferita in zona industriale,che faceva, e fa ancora, i chiusini di ghisa. |
||||||||||
|
Di fronte, dall’altra parte della strada, c’è la casa dei Povoleri, che vi abitano dal 1927 e hanno esercitato attività di commercianti di bestiame. |
||||||||||
|
Avevano una fattoria , affittata in parte all’Ispettorato agrario per la fecondazione bovina artificiale. |
||||||||||
| L’attività è cessata, ma la casa e le strutture varie ci sono ancora, e vi abita il signor Enzo Povoleri che racconta tutto questo. | ||||||||||
|
Anche dove attualmente c’è l’altra pizzeria, 2Fogher, c’era un’osteria, che ha cambiato più volte gestione. |
||||||||||
|
Se torniamo indietro, allontanandoci dalla città, troviamo il ristorante Storione. |
||||||||||
|
Quel locale era un’osteria, detta ’Do boti’, gestita, prima degli inizi del Villaggio, da una signora molto energica, che fumava il sigaro e sapeva far rigare dritti i suoi avventori. |
||||||||||
 |
In viale Trento, tra il fiume Bacchiglione e la roggia Seriola, ora interrata, si svolgevano diverse attività. |
|||||||||
|
C’erano i Bonvicini, commercianti di ferro, più o meno di fronte ai Saveriani e un negozio di abbigliamento e merceria. |
||||||||||
|
Sempre su viale Trento c’era il laboratorio di falegnameria di Calibran, che faceva anche i biliardi. |
||||||||||
|
Lungo il Bacchiglione scendevano i barconi dei ‘sabionari’. |
||||||||||
|
Le cave di sabbia erano alla confluenza del torrente Orolo col Bacchiglione, nella zona Capitello. |
||||||||||
|
Poi i barconi scendevano verso la città, scaricavano la sabbia vicino a ponte Pusterla, ma anche all’altezza di viale Trento. |
||||||||||
| Quindi c’era il traffico dei carri per il trasporto della sabbia. | ||||||||||
|
Su questi barconi, ornati con fiori e bandierine, nei giorni di festa, durante la bella stagione, si poteva scendere in città cantando e ballando, come su balere in movimento, lungo il fiume, racconta Armando Pavan, attento ‘custode’ di memorie. |
||||||||||
|
Sempre sull’argine del fiume, dove attraccavano i barconi dei ‘sabionari’ si trova un bel ‘capitello’ dell’Ottocento, che sta proprio dietro le cosiddette case del Barba. |
||||||||||
|
Una parte delle casette allineate su viale Trento, infatti, sono state costruite, per sé e per i figli, da Antonio Pavan, soprannominato Barba, nonno di Armando. |
||||||||||
|
Nato nel 1848 e morto nel 1908, qualche anno prima di morire, intorno al 1905, ha costruito queste case, che hanno conservato il suo nome, anzi il suo soprannome. |
||||||||||
|
E’ una delle figure ‘mitiche’ della zona; mediatore di prodotti agricoli, esercitava un certo fascino, dicono le ‘leggende’ con la sua parlantina sciolta e la barba, appunto, che caratterizzava la sua figura. |
 |
|||||||||
|
Ancora sul Bacchiglione, di fronte all’attuale supermercato, dove c’è adesso una carrozzeria, c’era la fabbrica di botti dell’altro Miolo, Antonio, fratello di Lio. |
||||||||||
| Antonio Miolo aveva un’attività che si può definire industriale, ha avuto anche una ventina di dipendenti. | ||||||||||
|
C’era un intenso movimento nel cortile della fabbrica, molto nota anche fuori dal territorio di Vicenza. |
||||||||||
|
Le sue botti venivano vendute in diverse parti d’Italia. Nelle nostre storie l’attività dei ‘botari’ viene ricordata più volte, da persone diverse. |
||||||||||
|
Antonio Miolo era nato nel 1880 e aveva sposato Maddalena Augusta Pavan, figlia del Barba, legando così insieme le vicende di due delle famiglie più conosciute da queste parti. Hanno avuto 6 figli, cinque femmine e un maschio. |
||||||||||
|
Antonio Miolo è stato ucciso da un tedesco in ritirata il 28 aprile del 1945, nel cortile della sua fabbrica. |
||||||||||
|
Nel cimitero di Vicenza la lapide della sua tomba ricorda la barbarie di questa morte assurda e anche la sua qualifica di ‘industriale’ |
||||||||||
|
|
L’attività continua col figlio,Ferdinando, e quando questi muore, a soli 33 anni, viene portata avanti da uno dei generi, Antonio Fortunato, fino agli anni Sessanta. |
|||||||||
|
Viale Trento era una delle uscite importanti di Vicenza verso nord, perciò aveva la sua stazione del dazio, nell’angolo di verde ora vuoto vicino al campo nomadi. |
||||||||||
|
Per comprendere meglio l’importanza di viale Trento dobbiamo tener presente che fino a cinquanta, sessanta anni fa non c’era viale Diaz e non c’era neppure via Pecori Giraldi, quindi non c’era la ‘rotonda delle cinque strade’ |
||||||||||
|
La statale 46 era percorsa da un traffico vivace. |
||||||||||
|
Vi passava il ‘tram’ che andava al Moracchino, i carri per il trasporto di varie merci, le automobili benché ancora rare, e soprattutto tante biciclette. |
||||||||||
|
Non per niente c’erano ben tre osterie, luoghi di sosta e di ristoro per tanta gente di passaggio. |
||||||||||
|
L’immagine che viene fuori da queste poche notizie è quella di una parte della città, appena fuori le mura, molto dinamica, indaffarata in varie attività produttive, che sono collegate al lavoro agricolo ma anche a quello industriale e di ricostruzione urbanistica. |
||||||||||
|
Il Villaggio del Sole si inserisce in questo contesto, con cui ha molti punti di contatto, quasi come continuazione e completamento |
||||||||||
